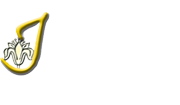Super User
Beata Maria di San Giuseppe
«Le vergini! Non hanno sposato un uomo, ma Dio. Non hanno pochi figli, ma molti: tutti quelli che il Signore ha messo sulla loro strada: figli che come e più d’una madre naturale beneficano, incoraggiano, aiutano, istruiscono, sostengono, se vicini, attendono sempre se lontani, tutto sperando con la carità che è loro natura, con la preghiera presso lo Sposo loro onnipotente ed onnipresente».
di don Enrico Pepe
Ci sono persone che fin dall’infanzia sentono la chiamata di Dio alla verginità con una lucidità che ci lascia sconcertati. È possibile che un ragazzo di dieci anni come San Luigi Gonzaga o una fanciulla di tredici come Laura Cardozo – e tanti altri – facciano il voto di castità sapendone la portata? La risposta positiva è comprovata dalla loro esistenza vissuta gioiosamente su quella linea senza tentennamenti o ripensamenti.
Una fanciulla innamorata di Dio
Laura Evangelista Alvarado Cardozo nacque a Choroni, un paesino verso il centro-nord, sulle spiagge dei Caraibi, nello Stato di Aragua in Venezuala il 25 aprile 1875 da genitori cristiani. A cinque anni la famiglia si trasferì nella capitale dello stato, a Maracay, dove la bambina iniziò i suoi studi.
A tredici anni fece la Prima Comunione e fu allora che sentì la spinta interiore di consacrarsi a Dio e fece il voto di castità. Era la festa dell’Immacolata. La figura della Vergine resterà sempre la sua guida con l’impegno di imitarla.
A 17 anni vestì lo scapolare della Vergine del Carmine insieme ad altre compagne ed entrò tra le Figlie di Maria, fondate in parrocchia nel 1893 dal sacerdote López Acevedo. Laura aveva sempre aiutato le varie iniziative della comunità parrocchiale e, quando il parroco costruì nella città il primo ospedale dove i poveri venivano accolti e curati, contava soprattutto su di lei, ormai ventiquattrenne e le affidò la direzione e l’amministrazione della nuova opera.
Cofondatrice
In breve tempo si formò attorno a lei un gruppo che condivideva il suo spirito di donazione e il parroco, agostiniano recolletto, propose loro di costituire una congregazione di religiose che chiamò Agostiniane Recollette. Piacque l’idea e naturalmente Laura fu scelta come superiora e le fu dato un nome nuovo: Madre Maria di San Giuseppe.
Come avviene quasi sempre con le opere di Dio, la nuova fondazione fiorì con l’arrivo di molte vocazioni. Per la madre cresceva il lavoro: non doveva pensare solo all’ospedale, ma anche alla formazione delle nuove aspiranti alla vita religiosa. Lo Spirito Santo le diede il dono della sapienza per cui, nonostante non fosse molto istruita, aveva tanto buon senso e tanta esperienza delle cose di Dio da innamorare le giovani a vivere il suo carisma. E con loro allargò il raggio d’azione costruendo orfanotrofi, ricoveri per mendicanti, ospedali, scuole e altre opere, sempre per venire incontro ai poveri.
La sua lunga vita trascorse tra questi due amori che erano: Gesù con cui conversava nella preghiera e che riceveva con profonda fede nell’Eucaristia e Gesù che serviva con estrema delicatezza nei poveri. Nella città tutti la conoscevano e l’ammiravano: era diventata il rifugio di ogni umana miseria.
Quando a 92 anni lasciò questo mondo, il 2 aprile 1967, gli abitanti di Maracay piansero la sua scomparsa, ma quando Giovanni Paolo II la proclamò beata, il 7 maggio 1995, tutti i venezuelani fecero gran festa, perché era la prima volta che una venezuelana veniva elevata agli onori degli altari.
Una madre adottiva per molte giovani e maestra di virtù
24 febbraio - Beata Josefa Naval Girbés
di Enrico Pepe
 «Josefa Naval Girbés, privata nell’infanzia dell’affetto della madre terrena, trovò conforto nel totale affidamento di sé alle sollecitudini della Madre celeste».
«Josefa Naval Girbés, privata nell’infanzia dell’affetto della madre terrena, trovò conforto nel totale affidamento di sé alle sollecitudini della Madre celeste».
Con queste parole Giovanni Paolo II nell’Angelus del 25 settembre 1988 poneva in rilievo una caratterista della vita di Josefa che nella sua non facile esistenza cercò sempre di “rivivere Maria” con un amore totalitario verso Dio e una donazione continua e gioiosa verso il prossimo, aiutando soprattutto le giovani a valorizzare la propria dignità di donne e a realizzare nella vita il prezioso disegno che Dio ha pensato per ognuna di loro.
Gemma di una famiglia di santi piemontesi
San Giuseppe Allamano
di Enrico Pepe
 Giuseppe Allamano ci ricorda che per restare fedeli alla nostra vocazione cristiana occorre saper condividere i doni ricevuti da Dio con i fratelli di ogni razza e di ogni cultura; occorre annunciare con coraggio e con coerenza il Cristo ad ogni persona che incontriamo, specialmente a coloro che ancora non lo conoscono.
Giuseppe Allamano ci ricorda che per restare fedeli alla nostra vocazione cristiana occorre saper condividere i doni ricevuti da Dio con i fratelli di ogni razza e di ogni cultura; occorre annunciare con coraggio e con coerenza il Cristo ad ogni persona che incontriamo, specialmente a coloro che ancora non lo conoscono.
Fu veramente fortunato l’Allamano, perché nipote di un prete santo, Giuseppe Cafasso, e alunno di un educatore anch’esso santo, don Bosco, e di questa fortuna egli seppe approfittarne bene.
Dicembre 2019
Natività, Gaudenzio Ferrari, 1511,
S.Maria Nascente, Arona.
Madonna della scodella
La tavola, La Madonna della scodella, fu realizzata da Correggio per la chiesa del Santo Sepolcro di Parma.
Il dipinto illustra un episodio dell'infanzia di Gesù narrato nel vangelo apocrifo dello pseudo-Matteo: nel corso del viaggio di ritorno in Palestina dopo la fuga in Egitto, durante una sosta all'ombra di una palma da dattero, la sacra Famiglia si sarebbe sfamata grazie alla pianta che, straordinariamente piegata, offriva i suoi frutti ai viaggiatori.
Settembre 2019
Il Riposo nella fuga in Egitto di Gregorio dei Ferrari (Spagna, 1560-1627) riflette lo studio e la copia dell’opera di Correggio, la cui influenza si sente fortissima nell’Estasi di San Francesco e in quest’opera sempre per la Chiesa di San Siro a Genova. Codifica il suo stile caratterizzandolo con eleganti figure allungate, movimento a spirale ascendente e fluida morbidezza.
Luglio 2019
Il Riposo nella fuga in Egitto di Juan Sanchez Cotan (Spagna, 1560-1627) è una delle opere più famose di questo artista che divenne famoso sia per le sue tele su scene religiose, sia per i ritratti e nature morte. Nel 1603 scelse la vita monastica e morì nella Certosa di Granada. L’opera si trova nella chiesa della stessa certosa.
Assistenza "materna" di Giuseppe
Il particolare della "Sacra Famiglia con Giovanninio", conservata a Udine a cura della Fondazione Friuli, è un'opera dai graffi forti e quasi ruvidi pur con un senso del sacro che permane dai volti e specialmente dalla serenità di fondo dei personaggi. Lo stile è tipico della produzione di Nicolò Frangipane, artista eclettico di cui si conservano numerose opere firmate e alcune a lui attribuite, specie nel nord Italia.
Secondo alcuni studiosi, il Frangipane nacque nel 1555 a Tarcento, in Friuli, da Nicolò, esponente di una nobile e antichissima famiglia. Dal 1583 al 1588 soggiornò probabilmente nelle Marche e a Rimini; nel 1593 è di nuovo a Venezia, dove dipinse una pala per la chiesa dei Frari. Si ipotizza sia stato alunno presso Tiziano. Il suo stile risente della pittura di Giorgione come di quella di Tiziano o del Campagnola, e risulta un anello di congiunzione tra il giorgionismo del primo Cinquecento. L'opera manifesta una sacralità quasi "laica", senza particolari simboli religiosi. La concentrazione, il silenzio, la pace sono i tratti caratteristici dei personaggi come avvolti dal mistero del divino che si mischia con l'umano.
Porta del cuore sempre aperta
di Stefania Colafranceschi
Lo sguardo di san Giuseppe è diretto al Bambino Gesù, a cui porge un vassoio di cristallo contenente mele, pere, ciliegie, frutta di carattere simbologico, disposta a sfumatura di colore dal giallo tenue al rosato, al rosso carico, per suggerire il percorso verso la Passione, trovandosi i frutti vermigli più distanti dal Figlio.
Una piccola pera, simbolo insieme alla mela del peccato originale e quindi del suo riscatto del mondo, è il dono che unisce in un gesto significativo, la mano di Maria offerente e del Bambino. Il gesto sta anche a sottolineare che il progetto della redenzione si attua attraverso l’intercessione di Maria, manifestatasi alle nozze di Cana.
Una linea ideale attraversa in diagonale il dipinto, a partire dal volto di san Giuseppe, in assorta contemplazione: percorre la gestualità del dono tra Madre e Figlio, e si prolunga nell’accentuata piega della veste azzurra della Madonna. Le altre pieghe del manto descrivono luminescenze radiali attorno al corpo di Gesù, il cui sorriso composto è l’unica nota di vivacità, tra gli sguardi di Maria, san Giuseppe e sant’Anna, connotati di mestizia.
Il Bambino è rappresentato verticalmente, richiamando il Crocifisso: è inscritto in uno spazio triangolare, una piramide rovesciata, delimitata dal gesto di Maria a sinistra e il volto di sant’Anna a destra. In tal modo il pittore El Greco esplicita il progetto divino, ponendo il Bambino Gesù al centro di una articolata scena familiare, secondo un genere invalso col nome di Sacra Famiglia allargata, di cui abbiamo esempio in un’incisione della Biblioteca Casanatense di Roma, opera del grande incisore rinascimentale Luca di Leyda (1494-1533), dove è proprio san Giuseppe, al centro, a donare il frutto paradisiaco al Bambino Gesù.
Gesù accetta i tre frutti
Una raffigurazione carica di sentimento questa Sacra Famiglia di Onorio Marinari (1627-1716). Dominante è il gesto del padre offerente, che guarda il Bambino con espressione di profonda partecipazione e intimo trasporto. Il Figlio è assorto, mentre prende dalla sua mano i tre piccoli frutti, che richiamano ‒ per il loro numero e il color rosso vivo ‒, il suo destino di Salvatore, attraverso la Passione e Morte.
Maria sostiene il braccio di Gesù, partecipe del messaggio che promana da quei frutti, fulcro della rappresentazione. A partire da un gesto semplice e quotidiano, eppure denso di significato umano e spirituale, si manifesta il presagio del disegno divino, un progetto di Vita che il Figlio dona al genere umano con l’offerta di sé. La mela, nel linguaggio dei simboli, era fin dall’antichità un simbolo di amore, per la sua dolcezza. Nell’arte cristiana allude alla Redenzione operata da Cristo per il riscatto degli uomini. Il numero tre è il numero sacro per eccellenza: tre sono le persone della Trinità, tre gli arcangeli, tre le virtù teologali. Il Vangelo narra che la Resurrezione avvenne il terzo giorno dopo la Crocifissione, la condanna comminata al Signore Gesù, all’età di trent’anni.
Nel Vecchio Testamento ricorre il triplice olocausto, e la purificazione nel terzo giorno dopo il seppellimento dei defunti.