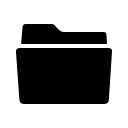
Iniziative Pia Unione (175)
Dio non è nel terremoto ma nella fraternità delle persone
Written by Super User Per il terremoto di Messina 1908, don Guanella offerse la sua opera. Per il terremoto delle Marsica, il 15 gennaio del 1915, nella zona di Avezzano, don Guanella andò di persona e soccorrere i terremotati e, soprattutto, con don Bacciarini, presente nei luoghi della desolazione, organizzò un’assistenza sul luogo e ospitò nella sue case di Roma Trionfale e san Pancrazio centinaia di profughi soprattutto anziani e orfani. Un’isola di benessere la costituì anche a Ferentino, dove decine di terremotati hanno potuto trovare assistenza materiale e morale. L’esperienza paurosa del terremoto è drammatica poiché è un rovesciamento della vita.
Per il terremoto di Messina 1908, don Guanella offerse la sua opera. Per il terremoto delle Marsica, il 15 gennaio del 1915, nella zona di Avezzano, don Guanella andò di persona e soccorrere i terremotati e, soprattutto, con don Bacciarini, presente nei luoghi della desolazione, organizzò un’assistenza sul luogo e ospitò nella sue case di Roma Trionfale e san Pancrazio centinaia di profughi soprattutto anziani e orfani. Un’isola di benessere la costituì anche a Ferentino, dove decine di terremotati hanno potuto trovare assistenza materiale e morale. L’esperienza paurosa del terremoto è drammatica poiché è un rovesciamento della vita.
Sorella morte ci vive accanto, appartenendo alla vita
Written by Super User Don Guanella è andato più in là di san Francesco, ha detto che la morte non solo ci è consanguinea come sorella, ma è madre di vita.
Don Guanella è andato più in là di san Francesco, ha detto che la morte non solo ci è consanguinea come sorella, ma è madre di vita.
È sul metro di questa madre che noi dovremmo misurare i passi della vita. Recentemente papa Francesco ha nominato mons. Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Subito nel cuore del presidente dell’Accademia della vita è riecheggiato l’eco affettuosa della “sorella morte” e ha pubblicato un volume sulla dignità del vivere e del morire.
Per gli anziani recuperare competenza e attenzione
Written by Super Userdi Flavia Caretta
 Un fenomeno spiacevole che si va sempre più diffondendo è il poco rispetto per le persone anziane. Il modo migliore di prevenire abusi e maltrattamenti è con tutta probabilità quello di investire sulla cultura, sul tema del valore che noi attribuiamo alla persona in genere, anche a livello sociale.
Un fenomeno spiacevole che si va sempre più diffondendo è il poco rispetto per le persone anziane. Il modo migliore di prevenire abusi e maltrattamenti è con tutta probabilità quello di investire sulla cultura, sul tema del valore che noi attribuiamo alla persona in genere, anche a livello sociale.
Penso si debba ripartire dall’idea che oggi l’anziano ha ancora un elevato “valore” sociale.. La società e le istituzioni focalizzano sempre più le loro attenzioni su altre età della vita, ed è encomiabile. Tuttavia l’anziano dovrebbe tornare a essere universalmente considerata una componente sociale essenziale. Da questa piattaforma di valori condivisi, potranno poi scaturire politiche socio-assistenziali e investimenti pubblici.
a cura di Graziella Fons
Quando si dice di una persona che è un “galantuomo”, si vuol rilevare quel grappolo di virtù umane che rendono positiva un’esistenza. Il beato cardinal John Henry Newman nel descrivere la qualifica di galantuomo diceva: «Essere galantuomo significa mostrare considerazione per gli altri, è l’equivalente di amare il prossimo come se stessi». Nella vita di ciascuno di noi abbiamo conosciuto persone, uomini e donne, meritevoli di questa definizione.
Un plebiscito per quest’attestazione, con certezza lo possiamo attribuire a don Vincenzo Savio, vescovo di Belluno-Feltre il 31 marzo 2004 all’età di cinquantanove anni. La sua giovane età, ma, soprattutto, la testimonianza del suo entusiasta zelo apostolico hanno promosso un coro di simpatia nei pochi anni in cui è stato vescovo nella diocesi Belluno-Feltre. Perché ne scriviamo? Perché don Vincenzo, come si faceva chiamare anche da vescovo, nelle ultime settimane della sua malattia mortale ha voluto che la porta dell’arcivescovado fosse aperta così che i suoi diocesani potessero dargli un “Addio”, così, “consegnarlo a Dio”, al momento della sua morte. Ci fu una grande partecipazione alle vicende della sua salute, soprattutto, per benefica e incoraggiante prospettiva pastorale che aveva suscitato nei tre anni della sua missione episcopale.
 Dal numero precedente della nostra rivista, padre Giovanni Cucci ha iniziato a trattare una nuova tematica per offrire un aiuto, per accompagnarci nello «spazio della fragilità» che riguarda comunque l’esistenza umana. Come introduzione al suo volume «Abitare lo spazio della fragilità. Oltre a cultura dell’homo infirmus» (ed. Ancora, euro16,00) riporta il dialogo di una scena di un film del celebre regista Woody Allen che proponiamo come beneficio ai lettori. Il nostro desiderio è il tentativo di offrire una scialuppa al nostro disagio fisico per accendere una scintilla di speranza.
Dal numero precedente della nostra rivista, padre Giovanni Cucci ha iniziato a trattare una nuova tematica per offrire un aiuto, per accompagnarci nello «spazio della fragilità» che riguarda comunque l’esistenza umana. Come introduzione al suo volume «Abitare lo spazio della fragilità. Oltre a cultura dell’homo infirmus» (ed. Ancora, euro16,00) riporta il dialogo di una scena di un film del celebre regista Woody Allen che proponiamo come beneficio ai lettori. Il nostro desiderio è il tentativo di offrire una scialuppa al nostro disagio fisico per accendere una scintilla di speranza.
Impariamo una valanga di saperi, ma non a morire
Written by Super Userdi Graziella Fons

E' davvero strano che in mezzo alla valanga di saperi utili e inutili che andiamo accumulando per tutto il corso della vita che non rientri questo: imparare a morire. La contemporaneità ha fatto della morte il suo tabù, il più temuto e occultato, e ci lascia completamente impreparati ad affrontare la naturalità con cui la vita la abbraccia. La morte appare come un’interruzione, un interdetto del linguaggio più sconveniente di una stupidaggine, un dolore da vivere di nascosto, una intromissione che non mettiamo mai in conto, in nessun momento. Sulla morte non sappiamo che dire, neppure cosa pensare. È veramente una carenza enorme.
L’Alzheimer non ha travolto la storia di Bill e Glad
di Graziella Fons

La pagina evangelica delle beatitudini non è solo la descrizione di un modo di essere per essere contenti d vivere, ma il riconoscimento che nel mondo l’annuncio delle beatitudine è carne della storia umana. Già vivono con noi i puri di cuore, i misericordiosi, coloro che piangono per le tremende fatiche della vita, per la perdita prematura di persone care.
Anche le fatiche innegabili della vita matrimoniale sostenute con forza e perseveranza già rivelano un ventaglio di un umanesimo costantemente in bocciolo in attesa di fiorire per il canto delle beatitudine. Uno degli ingredienti per poter cantare la beatitudine è la preghiera.
Non neghiamo ai piccoli di scoprire i lati bui della vita
Written by Super UserAi bambini tante volte viene evitato qualsiasi sforzo
di Graziella Fons

Il dolore dei bambini costituisce lo scoglio sul quale s’infrange la nostra rabbia di fronte al male nel mondo in cui i bambini sono vittime innocenti. L’irruzione di Gesù nella vita dell’umanità ha sconvolto ogni logica umana e là dove Gesù ha trovato la sua morte ignominiosa è spuntata la luce della speranza. Se la tenerezza di Dio nel cuore di Gesù ha trionfato sull’egoismo umano, allora si ha diritto di guardare il futuro illuminato dalla speranza. È una speranza che si modella lungo i sentieri tortuosi della vita. La palestra, dove si genera questo plasma divino, dono del Dio della vita, è la famiglia. Papa Francesco ha detto che «la famiglia da sempre è “l’ospedale” più vicino. Sono la mamma, il papà, i fratelli, le sorelle, le nonne che garantiscono le cure e aiutano a guarire». Gesù si è fatto uno di noi per conoscere il peso del soffrire e dare credito alla sua parola di consolazione; infatti: «Nessuna parola può essere credibile, se non sappiamo abitare i luoghi della sofferenza».
Osservando le tre “Pietà” del sommo artista
di Mario Carrera
 La fede non solo ispira la fantasia dell’artista, ma lavora e plasma la sua stessa vita. Questa considerazione è evidente nelle opere artistiche di Michelangelo e, in particolare, nelle tre "Pietà" che egli ha scolpito. All’età di ventiquattro anni ha scolpito la “Pietà”, quella più nota, la “Pietà” per eccellenza che ammiriamo nella basilica di san Pietro a Roma. È un inno all’amore di una giovane madre che perde un figlio in modo drammatico. Un inno alla fede e alla rassegnazione. Con il passare degli anni il dramma del morire bussa alla vena artistica dell’artista fiorentino e la morte prende il volto nella “Pietà”. Le sculture delle tre “Pietà” nella vita dell’artista hanno un itinerario quasi privato. A ventiquattro anni scolpisce una bellezza sontuosa, pur nel dramma della morte del Figlio di Dio. Le ultime due “pietà”, quella del Museo del duomo di Firenze e quella del Castello Sforzesco di Milano, sono lo specchio del suo stato d’animo di fronte alla morte. “L’incompiuta”, a Firenze, nella fisionomia di Nicodemo che sorregge il Cristo ci dona il suo autoritratto, il suo volto. La “Pietà” di Milano, nominata abitualmente “Pietà Rondanini”, è l'ultima opera di Michelangelo. Ad essa il Maestro dedicò gli ultimi pensieri e anche le ultime ore di vita.
La fede non solo ispira la fantasia dell’artista, ma lavora e plasma la sua stessa vita. Questa considerazione è evidente nelle opere artistiche di Michelangelo e, in particolare, nelle tre "Pietà" che egli ha scolpito. All’età di ventiquattro anni ha scolpito la “Pietà”, quella più nota, la “Pietà” per eccellenza che ammiriamo nella basilica di san Pietro a Roma. È un inno all’amore di una giovane madre che perde un figlio in modo drammatico. Un inno alla fede e alla rassegnazione. Con il passare degli anni il dramma del morire bussa alla vena artistica dell’artista fiorentino e la morte prende il volto nella “Pietà”. Le sculture delle tre “Pietà” nella vita dell’artista hanno un itinerario quasi privato. A ventiquattro anni scolpisce una bellezza sontuosa, pur nel dramma della morte del Figlio di Dio. Le ultime due “pietà”, quella del Museo del duomo di Firenze e quella del Castello Sforzesco di Milano, sono lo specchio del suo stato d’animo di fronte alla morte. “L’incompiuta”, a Firenze, nella fisionomia di Nicodemo che sorregge il Cristo ci dona il suo autoritratto, il suo volto. La “Pietà” di Milano, nominata abitualmente “Pietà Rondanini”, è l'ultima opera di Michelangelo. Ad essa il Maestro dedicò gli ultimi pensieri e anche le ultime ore di vita.
Medico e infermiere come garanti dei diritti del malato terminale
di Flavia Caretta
 Non si può dimenticare che l’elemento centrale in medicina, ma ancor più nella fase terminale, è trovare e mantenere con il paziente un canale di comunicazione, perché possa esprimere i suoi bisogni, le sue paure, i suoi interrogativi, cercando di far superare il senso di solitudine e di isolamento che spesso lo condizionano.
Non si può dimenticare che l’elemento centrale in medicina, ma ancor più nella fase terminale, è trovare e mantenere con il paziente un canale di comunicazione, perché possa esprimere i suoi bisogni, le sue paure, i suoi interrogativi, cercando di far superare il senso di solitudine e di isolamento che spesso lo condizionano.
More...
Solidarietà e accoglienza i requisiti per accompagnare all’ultima frontiera
Written by Super User Ivan è stato un uomo che ha trascorso la sua esistenza ad insegnare «il mestiere di vivere» umano. Essendo maestro di vita, negli anni della sua esistenza ha incontrato una serie innumerevole di persone e la moglie Nadège ha dovuto «condividere» il marito con tanti uomini e donne che si erano rivolti a lui alla ricerca di un aiuto per superare gli ostacoli del loro vivere.
Ivan è stato un uomo che ha trascorso la sua esistenza ad insegnare «il mestiere di vivere» umano. Essendo maestro di vita, negli anni della sua esistenza ha incontrato una serie innumerevole di persone e la moglie Nadège ha dovuto «condividere» il marito con tanti uomini e donne che si erano rivolti a lui alla ricerca di un aiuto per superare gli ostacoli del loro vivere. di Mario Melazzini
Malattia, dolore e il ruolo del medico
 Da medico e da paziente, ho letto con molto sconcerto la testimonianza del medico sardo che ha ammesso di aver «addormentato migliaia di persone, in un centinaio di casi sono andato oltre. L’ho fatto ogni volta che era necessario, ma non ho un elenco. Non mi sono mai pentito, anche perché erano i pazienti a chiedermi di intervenire. In tutte le situazioni non c’era altra via d’uscita. Questa è una pratica consolidata in tutta Italia». Come si può sostenere che in tutta Italia certi comportamenti siano consolidati: con molta fermezza dico che non è così! Di fronte a tali affermazioni mi chiedo quale sia allora il significato del nostro ruolo di medico?
Da medico e da paziente, ho letto con molto sconcerto la testimonianza del medico sardo che ha ammesso di aver «addormentato migliaia di persone, in un centinaio di casi sono andato oltre. L’ho fatto ogni volta che era necessario, ma non ho un elenco. Non mi sono mai pentito, anche perché erano i pazienti a chiedermi di intervenire. In tutte le situazioni non c’era altra via d’uscita. Questa è una pratica consolidata in tutta Italia». Come si può sostenere che in tutta Italia certi comportamenti siano consolidati: con molta fermezza dico che non è così! Di fronte a tali affermazioni mi chiedo quale sia allora il significato del nostro ruolo di medico? Eutanasia: dialogo tra Bonaccorti e Avvenire
Caro direttore,
L’approdo all’eternità
 «Dobbiamo abituarci a far festa con “lo straniero” che è in noi, riconoscenti con quella gratitudine della benedizione dell’uliva - come scriveva nell’antichità Marco Aurelio -, la quale cadendo sul terreno ringrazia l’albero che l’ha prodotta».
«Dobbiamo abituarci a far festa con “lo straniero” che è in noi, riconoscenti con quella gratitudine della benedizione dell’uliva - come scriveva nell’antichità Marco Aurelio -, la quale cadendo sul terreno ringrazia l’albero che l’ha prodotta». 