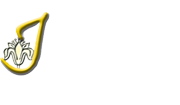di don Lorenzo Cappelletti
Nell’anno 2025 ci dedicheremo a illustrare la decorazione delle testate delle due navate laterali e dell’abside della Basilica di san Giuseppe al Trionfale. Entrambe queste strutture architettoniche non facevano parte della forma originaria della basilica; furono un portato dei lavori di ampliamento di essa, svoltisi in due fasi (1955-56: creazione dell’abside; 1970-71: creazione della crociera), ragion per cui le opere figurative che le ornano sono fra le realizzazioni più recenti in basilica, tutte successive al 1960.
Non seguiremo, peraltro, l’ordine cronologico – secondo il quale prima verrebbe la decorazione a mosaico dell’abside e dell’arco trionfale (1962-64), poi quella pittorica e in bassorilievo delle testate (1972) e infine la realizzazione del mosaico che inquadra il tabernacolo (2012) della Cappella dedicata a san Luigi Guanella –, ma cominceremo dai due grandi bassorilievi rettangolari, opera in travertino di Eros Pellini (1909-1993), un artista milanese già assai noto all’epoca nell’ambito dell’arte sacra. Un’opera in sé convincente, sia dal punto di vista artistico che spirituale, con la sua essenziale ed elementare spigolosità. Ci si chiede semmai se si armonizzi col resto della decorazione e ci passa per la mente che, se fosse stata dipinta, come spesso furono antichi bassorilievi e sculture, forse avrebbe potuto, in questo senso, avere un esito più favorevole. Ci siano perdonate queste valutazioni del tutto personali.
In testa alla navata di sinistra, il bassorilievo sull’architrave è dedicato a san Giuseppe, rappresentato al centro, fra due alberi, in figura di orante e dunque d’intercessore. Sette sono le forme d’intercessione raffigurate attraverso una serie di personaggi a sinistra e a destra di san Giuseppe. Prima di analizzarli, vorremmo però rilevare la presenza di una croce sull’albero accanto a san Giuseppe, a intendere il legno del riscatto dal peccato originale.
Venendo ai personaggi, troviamo all’estrema sinistra tre lavoratori (un contadino con la vanga; un uomo col fazzoletto al collo che si disseta, forse un minatore; un pescatore accovacciato): Giuseppe “Patrono dei lavoratori”. In quanto Giuseppe è “Sostegno delle famiglie”, il secondo drappello è costituito da un gruppo formato da un uomo e una donna abbracciati e un bambino che si stringe a entrambi. Il terzo gruppo è fatto invece di due soli personaggi, come quello (il quarto) che gli fa da pendant dall’altra parte di san Giuseppe. I due gruppi potrebbero incarnare il medesimo tema, visto che, in entrambi i casi, due sofferenti (questo esprime il loro essere a terra) sono sostenuti da due donne. Ma, nel primo caso, l’uomo seduto fissa intensamente la giovane che lo sorregge e che ha lo sguardo lontano, mentre nell’altro caso è la donna che sostiene e guarda amorevolmente la sofferente dallo sguardo lontano e desolato. Senza fare altri passaggi logici, ci spingiamo a dire che i due gruppi potrebbero essere rappresentativi rispettivamente di san Giuseppe “Speranza dei malati” e “Consolazione dei miseri”. Anche perché, in questo modo, si raggiunge il numero di sette patronaggi, simmetrico a quello delle sette opere di misericordia che contornano san Luigi Guanella nel bassorilievo dell’altra navata. Infatti, a seguire, troviamo due personaggi con la mitra seduti (in questo caso perché in cattedra) a rappresentare la Chiesa (san Giuseppe “Protettore della Santa Chiesa”), sovrastati da una donna giacente (san Giuseppe “Patrono dei morenti”) e infine come settimo gruppo, rivestiti di una tunichetta, una bambina e un bambino (san Giuseppe “Custode dei vergini”) sotto lo sguardo materno di una donna che sembra racchiusa in un alone di gloria (la santa Vergine ?).
Sull’architrave della Cappella dedicata a san Luigi Guanella (canonizzato solo nel 2011, e dunque qui ancora con l’aureola di beato quale fu dichiarato nel 1964), accanto al Santo raffigurato nel suo abito religioso (veste, fascia e cordone intorno al collo), con le braccia spalancate in un gesto di misericordia, sono rappresentate le sette opere di misericordia corporale.
In sequenza, dalla parte sinistra di don Guanella (per chi guarda): la vestizione di un ignudo e l’offerta di cibo e bevanda a una donna e a un uomo da parte di due laiche e il sostegno da parte di un giovane a un carcerato (così qualificabile per la presenza di un edificio alle sue spalle). Dalla parte destra di don Guanella, la cura di un’ammalata in carrozzella da parte di una religiosa guanelliana; il ricovero, significato da un doppio portico, dato a bambini e giovinetti; e infine la cura di un morto in primo piano da parte di un uomo che sembra avvolgerlo in un telo e di una donna che regge un piccolo crocifisso a indicare la “via”.
A proposito, anche in questo bassorilievo, come in quello dedicato a san Giuseppe, accanto a san Luigi Guanella sta con tutta evidenza un crocifisso: è il sacrificio redentore del Signore il cuore di san Giuseppe, e anche di san Luigi Guanella.