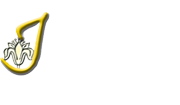Anche san Giuseppe ha “contribuito” a divulgare la devozione mariana a Palermo nella chiesa dei padri Teatini. Dove i fedeli invocano Maria come Madre della divina Provvidenza e attingono acqua da una fonte miracolosa
di don Gabriele Cantaluppi
“Quattro Canti” è il nome di una piazza ottagonale a Palermo, all'incrocio dei due principali assi viari, la via Maqueda e il Cassaro. È chiamata così per quattro apparati decorativi che ne delimitano lo spazio e che, realizzati nel secondo decennio del 1600, presentano elementi figurativi che, dal basso in alto, rappresentano la natura (le quattro stagioni), la società civile (i quattro re di Spagna), il regno dei cieli (le sante siciliane Agata, Ninfa, Oliva e Cristina). Il progetto è ispirato al crocevia delle Quattro Fontane di Roma, che però per una volta presenta una forma più dimessa della versione palermitana. Il temine deriva dalla parola greca “kanthos”, cioè “angolo”, e nell’italiano trecentesco denominava l’angolo formatosi dall’incrocio tra due strade.
In questa zona, dove trionfa il barocco siciliano, si inserisce anche uno degli esempi più monumentali di questo stile, la chiesa di san Giuseppe dei Teatini, edificata nel XVII secolo dall’architetto ligure Giacomo Besio. Di impianto basilicale a tre navate, con 34 colonne, in particolar modo le quattro che reggono la cupola sono alte ben 11 metri, impiegando materiale lapideo di produzione locale.
La nostra attenzione è stata attirata dalla cripta della chiesa, che ripete la pianta superiore, con funzione di chiesa ipogea, dedicata a santa Maria della Provvidenza. Come succede abitualmente, anche qui storia e leggenda si intrecciano, mentre la devozione dei palermitani ha escogitato questo titolo di Madonna della Provvidenza a motivo della bontà della Vergine nell’elargire grazie.
Fu il sacerdote teatino Salvatore Ferrari a costituire nel 1609 una confraternita, sotto il titolo di Servi o Schiavi di santa Maria della Sciabica. Come una sciabica (particolare rete da pesca che riesce a catturare ogni sorta di pesce), la congrega aveva lo scopo di accettare qualsiasi tipo di persona, senza distinzione di grado sociale, e di professare gli insegnamenti del Vangelo, invitando i congregati a farsi servi di Cristo e di sua Madre.
Si cercava anche un’effige della Madonna, a cui rivolgere le proprie preghiere e per esporla alla venerazione di tutti i confrati. Un altro frate teatino, Vincenzo Scarpato, originario di Napoli, possedeva un quadro che raffigurava la Madonna dell’Arco, venerata nella sua città. Decise di farla riprodurre su tela da alcuni pittori palermitani, che però non riuscirono a realizzare l’opera in modo soddisfacente. E qui subentra la tradizione a unire storia e pia creatività. Un giorno l’umile teatino, rientrando verso casa, trovò dinanzi a sé un vecchietto sconosciuto che, con molta cordialità, gli porse un involucro e gli disse: «Tieni, fratello Vincenzo, un quadro che ti piacerà di sicuro, conservalo, custodiscilo con rispetto e venerazione; farà tante grazie; e molti verranno a fargli visita, anche da lontano». Poi scomparve rapidamente.
Aperto l’involto, esso conteneva una tela che riproduceva esattamente l’immagine desiderata della Madonna dell’Arco, che la confraternita accolse ponendola sull’altare del proprio oratorio nella cripta della chiesa dei Teatini. Lo Scarpato, dopo una vita vissuta in fama di santità, in punto di morte rivelò che il vecchietto che gli aveva donato il quadro altri non era che san Giuseppe, che gli si era rivelato poi in frequenti apparizioni.
L’immagine mariana divenne presto oggetto di pietà popolare calda e sentita. A questo moto di venerazione venne ad aggiungersi anche il fatto che nel 1668 sotto l’altare si trovò una fonte d’acqua, ritenuta miracolosa, e poiché il ritrovamento avvenne il 15 gennaio, si stabilì che fosse quello il giorno solenne della celebrazione.
Grazie a quest’acqua si verificarono prodigi non solo di guarigioni, ma anche di conversioni profonde di persone, afflitte nel corpo e nello spirito, che fiduciosi accorrevano a ricevere quel dono che la Madonna della Provvidenza, ben due secoli prima dell’acqua di Lourdes, aveva voluto dare ai palermitani.
Presso la chiesa si conserva anche il “Libro d’oro”, dove si scrivono i nomi dei fedeli, sia vivi che defunti, posti sotto la protezione della Madonna della Provvidenza. Viene rinnovato ogni anno e il mercoledì che segue la seconda domenica dopo l’Epifania, esso è solennemente intronizzato sotto l’immagine della Madonna. A beneficio degli iscritti, viene celebrata una santa Messa tutti i mercoledì dell’anno. E poiché la devozione mariana è vera se conduce al suo scopo principale, che è l’unione con Gesù, per la preparazione alla festa della Madonna della Provvidenza e per la festa del Libro d’Oro si tengono tre giorni di solenne adorazione eucaristica.
Come abitualmente accade, anche qui sono nate tradizioni nelle quali fede e folclore locale si danno la mano. Anticamente nel giorno della festa si usava benedire delle nocciole offerte alla Madonna e poi donate ai devoti, avvolte in sacchetti di carta, sulla quale erano stampate le istruzioni per usare devotamente l’alimento benedetto. E ancora, i marinai del porto di Palermo, la sera della vigilia, bruciavano una barca davanti alla chiesa, quasi a indicare l’affidamento totale alla Vergine della loro vita non priva di rischi. La festa liturgica continua a celebrarsi, nonostante non ci sia più la solennità di un tempo, e sono molti i palermitani che accorrono in questo giorno nel maestoso tempio dei Teatini per ottenere grazie dalla Vergine e attingere l’acqua santa, antesignana della più famosa acqua di Lourdes. In anni recenti il quadro originale è stato trasferito nella chiesa superiore, mentre nella inferiore è rimasta una copia.