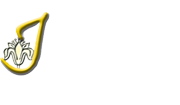Con la fedele osservanza della Legge mosaica, Giuseppe e Maria introducono il figlio nel disegno salvifico del Padre. è questo il compito perenne dei genitori
di mons. Silvano Macchi
Tra gli eventi dell’infanzia di Gesù, il Vangelo di Luca fa memoria della purificazione della madre e della presentazione al tempio del bambino.
È un brano lungo e articolato (Lc 2, 22-40) che nella liturgia viene proclamato sia nella festa della Presentazione (la Candelora) che in quella della Sacra Famiglia.
La scena evangelica – che è il seguito naturale della circoncisione e dell’imposizione del nome – descrive tutta la Sacra Famiglia riunita nel tempio di Gerusalemme, il luogo dove la Legge mosaica trovava il suo compimento. Proprio la Legge è il fulcro di tutto il brano; infatti il termine ritorna cinque volte, sia in riferimento al sacrificio offerto in favore della madre, sia riguardo al rito della presentazione di Gesù, che erano le due prescrizioni inseparabili in vista della purificazione dopo la nascita di ogni bambino del popolo ebraico.
L’insistenza di Luca non mira evidentemente a proporre il rispetto di un formalismo legale, ma piuttosto a preparare il passaggio dalla Legge a Gesù Cristo mediante l’accoglienza dello Spirito Santo, come dimostrerà chiaramente l’apostolo Paolo: «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare coloro che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre» (Gal 4, 4-6).
Tralascio i versetti riguardanti la purificazione della madre, come anche il racconto dell’incontro con il giusto e timorato Simeone e la devotissima vedova Anna, per concentrarmi sulla figura di Giuseppe o più ampiamente sui gesti compiuti dalla Famiglia di Nazareth.
Si può supporre che Maria e Giuseppe fossero impazienti di portare Gesù al tempio, non solo per obbedire alla Legge, ma anche per sapere qualcosa di più di quel loro figlio. Così san Luca ci mostra i primi passi, importantissimi, compiuti dalla Sacra Famiglia, quando Giuseppe e Maria si recano a cercare nel tempio istruzioni da parte di Dio per adempiere con attenzione e gratitudine il compito che era stato loro affidato, difficile allora come ora: essere genitori.
Dovrebbe proprio essere così per ogni padre e madre anche nel nostro tempo. Presentare i figli al “tempio” dovrebbe servire a capire chi è davvero un figlio e rispondere ad alcune fondamentali domande: Quale benedizione è il figlio? Quale compito grandioso il figlio propone al padre e alla madre? Come essere bravi genitori? Domande sempre valide, ma particolarmente attuali e urgenti in un periodo di “emergenza educativa” come sono i nostri tempi. Sarebbe davvero necessario che nel “tempio”, cioè nelle comunità cristiane, i genitori trovassero persone di solida esperienza (come Simeone e Anna) o magari qualche sacerdote che “vede lontano”, che è ricolmo dello Spirito Santo, per chiedere fiduciosamente di essere indirizzati e illuminati nell’educazione cristiana dei figli.
È quello che, secondo le loro tradizioni, hanno fatto anche Maria e Giuseppe attraverso i gesti e i riti che hanno compiuto, mostrando così di essere autorevoli perché obbedienti e quindi capaci di insegnare al figlio la bellezza dell’ordine che regge il mondo. Maria e Giuseppe sotto questo profilo ben rappresentano il compito che ogni madre e padre devono responsabilmente assumersi.
Molto spesso i genitori preferirebbero non imporsi, ma così vengono meno al loro compito di autorità, magari giustificandosi con le banalità e i luoghi comuni della cultura dominante. Invece un padre e una madre – lo vogliano o meno – sono un’autorità per il figlio, rappresentano quel sistema di rapporti, di tradizioni, di memorie, di esempi che diventa solida radice e principio di stabilità. Non possono defilarsi, lasciando che la crescita e la formazione dei figli sia delegata al rapporto con i coetanei.
Essere “autorità” vuol dire svolgere un servizio, cioè far comprendere che la vita non può svilupparsi secondo il desiderio o il piacere, ma va indirizzata al bene nella prospettiva della crescita umana e della formazione cristiana.
Tornando al racconto evangelico, dopo aver compiuto i riti della Legge che inseriscono il bambino Gesù a pieno titolo nel popolo di Dio, la Santa Famiglia ritorna a casa. Il brano si conclude con un versetto che sintetizza tutta l’infanzia di Gesù fino ai dodici anni: «Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui» (Lc 2, 40). Vi è sottolineata in tal modo l’assistenza divina: il Padre si prende cura di lui non solo perché lo ama, ma anche perché ha un progetto per lui, e Gesù, sostenuto in questo modo, cresce e si fortifica.
Null’altro sappiamo di questo periodo; solo i vangeli apocrifi cercheranno di colmare fantasiosamente questa lacuna. Maria e Giuseppe ancora una volta sono obbedienti e compresi del loro compito: si fanno docili strumenti dell’opera di Dio che forma e fa crescere quel bambino in grazia e sapienza per prepararlo al suo compito nella vita.
San Giuseppe, che nelle Litanie è detto domesticae vitae decus, “decoro della vita domestica”, aiuti i genitori ad accudire i figli, a farli crescere con serenità e armonia, a indirizzarli sulle vie del bene, così che ogni casa e ogni famiglia non siano un rifugio, ma un luogo dove con libertà e amore si apprendono i valori fondamentali della vita, la prima e decisiva scuola dove imparare a diventare davvero “grandi”.