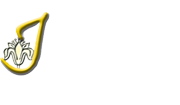È il grido del popolo di Dio, che la Chiesa ha ascoltato fin dalla proclamazione dei primi Giubilei. Grido rivolto a Cristo, speranza che non delude e guarisce le ferite di ogni uomo
di Rosanna Virgili
L'anno giubilare 2025 appena iniziato è un periodo che la Chiesa cattolica celebra con gioia e letizia affatto speciali. Il computo degli anni è importante quando si parla di “Giubileo”, perché si tratta di un evento che rivela la grazia che scorre nel tempo della Chiesa. Esso si innesta dunque sia sul tempo teologico e salvifico, sia su quello storico, sul terreno del “già e non ancora” della Chiesa stessa. Ciò conduce a dire che nessun Giubileo è uguale all’altro nell’esperienza concreta che i cristiani ne fanno, non solo dal punto di vista socio-culturale, ma anche da quello morale e spirituale.
Proprio nella Bolla di indizione dell’attuale Giubileo, il Papa rievoca quelli del passato – a cominciare dal primo di questa lunga serie, tenutosi nel 1300 – per ritrovare le ragioni storiche e spirituali da cui scaturì quell’iniziativa: «Mi piace pensare che un percorso di grazia, animato dalla spiritualità popolare, abbia preceduto l’indizione, nel 1300, del primo Giubileo. Non possiamo infatti dimenticare le varie forme attraverso cui la grazia del perdono si è riversata con abbondanza sul santo Popolo fedele di Dio. Ricordiamo, ad esempio, la grande Perdonanza che san Celestino V volle concedere a quanti si recavano nella Basilica di santa Maria di Collemaggio a L’Aquila, nei giorni 28 e 29 agosto 1294, sei anni prima che papa Bonifacio VIII istituisse l’Anno Santo. La Chiesa già sperimentava, dunque, la grazia giubilare della misericordia. E ancora prima, nel 1216, papa Onorio III aveva accolto la supplica di san Francesco, che chiedeva l’indulgenza per quanti avrebbero visitato la Porziuncola nei primi due giorni di agosto. Lo stesso si può affermare per il pellegrinaggio a Santiago de Compostela: infatti papa Callisto II, nel 1122, concesse di celebrare il Giubileo in quel Santuario ogni volta che la festa dell’apostolo Giacomo cadeva di domenica. È bene che tale modalità “diffusa” di celebrazioni giubilari continui, così che la forza del perdono di Dio sostenga e accompagni il cammino delle comunità e delle persone» (Spes non confundit, 5).
Il primo Giubileo si celebrò dunque sotto la grande spinta dei tantissimi pellegrini che stavano giungendo a Roma già alla fine del 1299. Dante Alighieri descrive questo enorme afflusso a San Pietro nella Divina Commedia, notando che per la grande folla si doveva rispettare il doppio senso di marcia sul ponte di fronte a Castel Sant’Angelo: «Come i Roman per l’essercito molto, / l’anno del giubileo, su per lo ponte / hanno a passar la gente modo colto, / che da l’un lato tutti hanno la fronte / verso ’l castello e vanno a Santo Pietro, / da l’altra sponda vanno verso ’l monte» (Inferno, XVIII, 28-33).
Sin dalle origini, il Giubileo è dunque una risposta della Chiesa a un’esigenza fortissima e diffusa nel popolo cristiano: il desiderio e il bisogno di assaporare la misericordia di Dio. Cioè di essere salvati dall’amore e per amore! Di essere liberati da ogni male, soprattutto dalla devastazione arrecata dal peccato, e di sperimentare quella libertà che solleva lo spirito dal peso della colpa, condannando la carne a soffocare nelle schiavitù. Non per nulla l’evento ispiratore del primo Giubileo è proprio la festa aquilana della Perdonanza che papa Celestino V volle offrire alle sorelle e ai fratelli in Cristo per donare loro grazia, giustizia e gioia. Potremmo davvero dire che il Giubileo nasce dal grido della povera gente, degli antichi pastori d’Abruzzo e di quanti ancora, come loro, sentono la morsa della fatica, dell’oppressione, della sopraffazione, della morte per fame o per guerra, della vita violata dei propri bambini, della potenza devastante degli umani che divorano altri esseri umani.
Sperare vuol dire…
All’origine del Giubileo c’è il coraggio di sperare. È l’opera di qualcuno che ha il coraggio di corrispondere alla speranza dei tanti. Papa Celestino si fece eco del grido del popolo e lo guidò in un pellegrinaggio di riscatto. La Perdonanza è una grande festa di liberazione dai danni che il peccato di ognuno procura a sé stesso e agli altri, all’intera comunità. La misericordia di Dio è come un grembo dove tutta la comunità umana rinasce, risorge, si rinnova. Ritorna bambina: libera e liberata dalla colpa, lavata dalle incrostazioni della morte. Rinnovare l’efficacia “sacramentale” del Giubileo comporta – ancor oggi – questo grido, questa consapevolezza, questo desiderio e questo bisogno: la coscienza di non potersi salvare da soli. Infatti nessuno può procurare a sé stesso la salvezza, vale a dire la pienezza della vita, senza l’abbraccio dell’Altro e degli altri, il loro perdono, il loro bene gratuito.
Ecco perché, in occasione del Giubileo si va insieme a Roma. Un viaggio che non serve – come qualcuno ha detto! – a “ritrovarsi con sé stessi”, che non è auto-referenziale. Al contrario, è un esodo da sé stessi, un passaggio da “io” a “noi”, una strada che spinge ad uscire e ad andare verso gli altri per camminare insieme, per comporsi in una “sinodia” (comitiva) verso la Casa e verso il Cuore di Dio nostro Amico, nostro Amato, nostro Padre, nostro Signore e Redentore.
«Tutti sperano» (Spes non confundit, 1), ha scritto papa Francesco. Ma l’oggetto della speranza non è affatto scontato. Molti, infatti, sperano in quello che hanno già e che hanno costruito essi stessi o che si sono procurati da soli, sperando di non perderlo; altri sperano di ritrovare qualcosa che avevano in passato e che hanno perduto; la maggior parte spera in cose materiali che servono a soddisfare individualisticamente ed egoisticamente sé stessi; molti altri pensano di poter ottenere vantaggi morali ma sempre personali o privati, come il proprio successo o la propria fortuna. Tutt’altro è la speranza cristiana! E tutt’altra è la speranza che la Chiesa accende per il Giubileo.