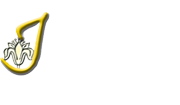La fase terminale della vita è per l’ammalato un momento critico e gravoso, ma da vivere cercando il senso e il valore. E chi assiste deve esercitare una presenza attenta e disponibile
di Vito Viganò e Cecilia Bisi
È misterioso il momento in cui, perso ormai il contatto con la realtà, la vita cessa e subentra la rigidità della morte. Questo momento è preceduto da un tempo breve, di cui quasi non ci si rende conto, nel caso di un ictus o di un grave incidente; più lungo, sovente molto, quando la fine è determinata dal degradarsi del corpo per una malattia. La fase terminale, quando si prolunga, è un tempo critico e gravoso per chi lo sta vivendo e per chi assiste.
Un tempo da vivere
Anche se ovvia, conviene richiamare qui un’osservazione. Può succedere che non si tengano nel dovuto conto le diverse esigenze dell’ultimo scampolo di esistenza. Eppure è legge della vita che questa la si debba spendere bene, in ogni momento. Per chi sta morendo le condizioni del vivere si fanno sempre più difficili e penose e diventa una sfida dare un senso a ogni giornata, coltivando l’impressione di averla spesa bene. Si può dire di avere ancora un “buon vivere”, se i disagi e il dolore sono contenuti e se il tempo è speso in quel che può ancora interessare, se i bisogni affettivi e sociali sono assecondati, e ci si consentono i piccoli piaceri del vivere di ogni giorno.
Si può forse pensare, per una fine imminente, che non ci sia più molto da fare, come se chi sta morendo non fosse già più con noi. Ma il malato terminale sembra ammonire: «Guardate che fino all’ultimo respiro sono vivo». E quando dolori e disagi sono affievoliti o scomparsi con le terapie adeguate, sono preziosi i momenti di relazione che il malato ha modo di vivere, con cose, confidenze, gesti e sorrisi da donare. Chi cura può trovare difficile dare valore e comprensione a queste fragilità, lentezze, stanchezze, ma resta il compito di una presenza attenta al malato rispettando la sua unicità, ascoltando i suoi bisogni, assecondando le richieste anche se esigenti. Più che fare qualcosa per l’altro, bisogna accompagnare, facilitare il gesto divenuto stentato o arduo, per consentire quel benessere che è ancora possibile. (Cecilia)
Un fisico che si degrada
Lungo il corso dell’esistenza le malattie sono state curate, grazie alle meravigliose cure mediche possibili oggi. Ma nella fase terminale la prospettiva cambia e la cura diventa accudimento del morente. L’esito probabile non è più la guarigione, ma l’esistenza che si conclude. Impotenti ad arrestare il ridursi della vitalità, si praticano le cure possibili almeno per frenare il degrado, ridurre dolore e disagio di sintomi fastidiosi, per consentire un vivere dignitoso. Si parla di interventi di palliazione, cioè di cure appropriate ad assicurare una condizione fisica accettabile, pur se compromessa dalla malattia.
Un bisogno di assistenza
L’aggravarsi del male comporta un bisogno di assistenza sempre maggiore. Accompagnare vuol dire allora essere a fianco e intervenire nelle esigenze quotidiane e nelle condizioni fisiche ridotte. Perché il paziente terminale riesce sempre meno ad occuparsene. Provvidenziale è dunque la presenza attenta e fattiva di chi può dare aiuto e sollievo. Si apprezza tanto la propria autonomia nel gestire le diverse incombenze del vivere, tanto che questo è uno dei valori inalienabili della condizione umana. Ma l’avanzare del male priva progressivamente chi sta morendo anche della sua autonomia e sorge l’esigenza di un aiuto a volte anche per le cose più semplici e intime. La dipendenza da chi accompagna può diventare una situazione inevitabile, con il suo carico di disagi e umiliazioni, se l’aiuto non viene dato con la discrezione e l’umanità dovuta.
Il concludersi dell’esistenza
È naturale che la prospettiva di una fine prossima solleciti reazioni emotive intense. L’addio alla vita è sovente carico di travaglio interiore, perché si fa fatica a capire il perché si debba morire. Se non lo si accetta, si rischia di restare attaccati ciecamente al poco di vita che rimane, come se si potesse evitare l’ineluttabile. Ma quando si accetta di morire come esito naturale e coerente del vivere, si prova anche il desiderio di tirare le somme dell’esistenza, di definire il senso di quel che si è vissuto, di dare risposte agli interrogativi perenni dell’esistenza. Si possono avere cose da sistemare, pendenze in sospeso da regolare, forse relazioni guastate che si desidera ricomporre. Dove sussiste una sensibilità maggiore ai valori dello spirito, assume un risalto urgente la dimensione religiosa, per l’inevitabile inquietudine che suscita il pensare a un “dopo” incombente e sconosciuto.
Ho incontrato e accompagnato centinaia di persone in fase terminale, procurando il sollievo possibile con le cure palliative. Tante, forse tutte, hanno lasciato una traccia in me. Quello che era più utile per loro era una presenza attenta e disponibile a quanto palesavano, senza fuggire davanti a domande scottanti, rivolte a bruciapelo: «Sto morendo? Quanto mi resta da vivere?». Ricordo il signor José, padre di un bimbo di cinque anni, con una malattia degenerativa che gli toglieva a brani le capacità e l’autonomia. Ci accoglieva abitualmente con un sorriso sereno. Ben lucido, ci confidava il bilancio della sua vita che portava avanti. L’abbiamo avuto in reparto per diversi mesi, abbiamo riso con lui e pianto nei momenti critici. Ogni venerdì alle cinque, con la famiglia attorno, ci offriva un goccio di Porto, a esprimere il valore di quei momenti vissuti insieme. (Cecilia)